
«C’era una specie di luce in quel sorriso», ha detto chi ha ucciso Padre Pino Puglisi. Non sono originale nel dire che questa frase colpisce tutti. Veniva ucciso 26 anni fa, il 15 settembre, giorno del suo compleanno.
Ha colpito anche me, ma mi ha anche interrogato. Che cos’era quella luce percepita anche da chi quel sorriso ha spento prima ancora di accorgersi che quel sorriso lo stava guardando? Che cos’era?
Ha scritto mons. Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo: «L’eroe della legalità, il martire della giustizia, con la sua morte apre paradossalmente un tempo nuovo, il tempo del dopo, per cui tanto il carnefice, l’assassino e i suoi mandanti, quanto i familiari e i colleghi devono scegliere come vivere un legame reso perenne dal sacrificio. La morte della vittima innocente diventa lo spartiacque del tempo di chi va oltre ma resta ad essa legato». «Il tempo che rimane — prosegue — diventa conversione e pentimento, rabbia e dolore, perdono ed eredità, resistenza e riscatto…. La vittima innocente cambia il tempo di chi continua dopo di lei e lo trasforma in spazio di libertà e di rinascita» (le citazioni sono tratte dal suo volume Siate figli liberi! Alla maniera di Pino Puglisi, San Paolo, 2018)
Ecco le mie domande: Che cos’era quella luce percepita anche da chi quel sorriso ha spento prima ancora di accorgersi che quel sorriso lo stava guardando? Che cos’era? Che cosa ha inaugurato «il tempo del dopo»?
Quel sorriso era due cose:
- la consolazione di Dio. Quando si affaccia la prova Dio non ci lascia soli. Don Pino aveva vissuto il suo calvario proiettando nel futuro il suo possibile sacrificio. Ma Dio non fa mancare nella tribolazione l’olio della sua consolazione, della sua grazia. Quel sorriso era la pace della presenza di Dio nel suo cuore. Chi lo ha ucciso ha visto Dio, permettetemi di dirlo così. Ha visto che Dio lo amava tramite la sua vittima. Questa è una cosa sconvolgente.
- era il sorriso del pastore che, percependo in un lampo, il pericolo non fugge, ma accoglie. Ed ecco il pastore: colui che vive della consolazione di Dio; colui che accoglie le pecore, anche quelle nere. In un momento nel quale l’odio sembra vincere e la paura sembra braccare i cuori, lo sguardo di don Pino ci aiuta a vivere. Aiuta a vivere noi come popolo di Dio ma anche come cittadini.
Due mesi prima della morte, in un’omelia, padre Pino denunciava pubblicamente le minacce che riceveva: «Oggi mi rivolgo ai protagonisti delle intimidazioni che ci hanno bersagliato. Parliamone, spieghiamoci! Vorrei conoscervi e conoscere i motivi che vi spingono a ostacolare chi cerca di educare i vostri figli al rispetto reciproco, ai valori della cultura e della convivenza civile».
E ancora: «Non è da Cosa nostra che potete aspettarvi un futuro migliore per questo quartiere. Il mafioso non potrà mai darvi una scuola media o un asilo nido dove lasciare i bambini quando andate al lavoro. Perché non volete che i vostri bimbi vengano a me? Ricordate: chi usa la violenza non è un uomo. Lo so che mi stanno ascoltando. Noi chiediamo a chi ci ostacola, di riappropriarsi della umanità ed io sono disponibile ad accompagnarli in questo cammino». E concludeva: «noi andiamo avanti. Perché, come dice San Paolo: “Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi?” (Rm 8,31)».
In questa conclusione si vede la saldatura tra il cittadino e il santo. È chiarissimo. Questa lezione dobbiamo recuperare a tutti i costi. Abbiamo bisogno di tornare a capire che cosa significhi essere cristiano cittadino. Ha scritto mons. Lorefice: «È il Vangelo che ci fa essere porta, casa, ospedale, campo, oratorio per tutti; e a tutti dobbiamo indicare la strada buona».
Padre Pino non si sostituiva all’assistente sociale né faceva ciò che avrebbe dovuto realizzare il Comune. Semplicemente sollecitava dalle autorità i servizi e le strutture a cui i cittadini avevano diritto. Di qui le prime legittime richieste: la fognatura al quartiere; poi l’apertura di una scuola media nel quartiere, un centro sociale, un distretto sociosanitario di base, un ritrovo per giovani e anziani.
Inoltre le richieste erano fatte non a titolo personale, ma insieme alla gente del quartiere. Questo comportamento era una rivoluzione, poiché insegnava ai cittadini a rivendicare liberamente i propri diritti.
La trasformazione da abitante a cittadino: questa è, a mio parere, una delle eredità di padre Pino, consapevole della costruzione del nostro destino, consapevole del fatto che questo destino era anche nelle sue mani. La sua era una forma dinamica e vitale di partecipazione.
Se dal Vangelo non si possono dedurre ricette politico-sociali, è chiaro però che il Vangelo giudica queste ricette.
Com’è possibile che l’egoismo oggi sembra plasmare l’animo di molti nostri concittadini?
Com’è possibile che i buoni cristiani dicano di riconoscere Cristo nel pane eucaristico e non riescano a farlo nel fratello in carne ed ossa?
È un rischio di idolatria ammantata da devozione…
Invece oggi sperimentiamo la paura e la povertà. Queste «se non ascoltate, se non interpretate e raccolte, creano diffidenza, isolamento, disillusione, frattura».
Il punto è che «le domande del nostro popolo, le sue pene, le sue battaglie, i suoi sogni, le sue lotte, le sue preoccupazioni, possiedono un valore ermeneutico che non possiamo ignorare se vogliamo prendere sul serio il principio dell’incarnazione. Le sue domande ci aiutano a domandarci, i suoi interrogativi ci interrogano» (Papa Francesco, Gaudete et Exultate 44).
Non possiamo più dare per scontato il cattolicesimo del nostro popolo. E il “nemico” non è più solamente la secolarizzazione, come abbiamo spesso ripetuto, ma è la paura, l’ostilità, la frattura dei legami sociali e la perdita del senso di solidarietà.
Che fare? Questo è un momento prezioso, in realtà. È un momento di discernimento, che deve avviarsi, a mio avviso, sulla base di alcune riflessioni.
Questo dovrebbe essere il compito della politica, della scuola, delle parrocchie: rompere l’isolamento, ascoltare il grido, raccontare il dolore, la fatica di vivere, e darle senso.
Ha scritto mons. Lorefice: «Oggi a questo compito spesso veniamo meno: viene meno la politica, che usa il disagio e non se ne fa carico; viene meno la Chiesa, quando riduce la fede ad una devozione individuale, che non investe tutta la vita e non si fa fonte di autentica comunità». E poi parla di una illusione: «Un’illusione pericolosa si sta diffondendo: che la chiusura, lo stare serrati, la contrapposizione all’altro siano una soluzione, siano la soluzione. Ma una civiltà che si fondi sul “mors tua, vita mea”, una civiltà in cui sia normale che qualcuno viva perché un altro muore, è una civiltà che si avvia alla fine». «È impossibile immaginare un futuro per la società senza un forte contributo di energie morali». L’energia morale del cristianesimo è il non considerare mai l’altro come nemico.
Scrivevo di un coinvolgimento popolare… Francesco dice che siamo «circondati da una moltitudine di testimoni», che «ci spronano a non fermarci lungo la strada, ci stimolano a continuare a camminare verso la meta» (Gaudete et Exultate, 3). Risuonano qui le parole del Pontefice che avevamo letto in Evangelii gaudium, lì dove aveva scritto di una «“mistica” del vivere insieme», di un «mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po’ caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio» (Evangelii gaudium, 87).
In questo senso anche la pietà popolare ci aiuta. Ci siamo dimenticati della pietà popolare: le confraternite, le feste patronali, i legami di popolo e di quartiere con l’Ecce homo e con l’Addolorata…
Scriveva Papa Francesco nel 2008: «La pietà popolare, in quanto manifestazione visibile e sensibile della religiosità popolare, è un modello dell’incarnazione della fede nelle realtà culturali, che le impregna e al tempo stesso se ne arricchisce; vale a dire, è un modello di inculturazione della fede. È sensibile, emozionale; non è né astratta né razionale. Si esprime secondo una svariata tipologia di pratiche devozionali in cui per mezzo di simboli si sperimentano valori religiosi e specificamente cristiani che si legano a diversi universi culturali trasformandosi in un mezzo di autoevangelizzazione. Possiamo comprendere bene la religiosità popolare soltanto se riconosciamo la cultura come un tutto in sé correlato. L’esperienza della fede propria della religiosità popolare scaturisce dalla stessa esperienza reale dell’uomo e si lega all’espressione di simboli, storie, miti, credenze, sogni. «Più che la parola e l’analisi, privilegia il simbolo, l’azione, il rito, il mito, il movimento, il bacio, il canto, la musica, i silenzi eloquenti, i balli, le candele e i fiori, eccetera».
Ecco tutte queste sono da intendere come occasioni favorevoli di rapporto tra cultura e fede, dove attuare l’opera di resistenza alla mafia e di liberazione delle nuove generazioni.
Il problema è che abbiamo una mentalità che, deturpando la sana natura religiosa dell’intercessione e della mediazione ardisce impadronirsene e spogliarla della sua carica di umanità, per ridurla a segno di potere.
Oggi c’è dunque bisogno di don Pino e della sua santità. Santi, non «santini». La santità è vedere la storia da parte di Dio, con i suoi occhi, pur rimanendo assolutamente con i piedi ancorati per terra. Si tratta di tornare al Vangelo sine glossa. Di tornare all’abc, dato forse troppo per scontato. È ora di tornare al contatto diretto con la gente, a convertire cuori e menti.
Don Pino si è fatto santo per strada. Tante volte Papa Francesco ha detto che preferisce una Chiesa che magari inciampa e si ferisce, ma che è per strada piuttosto che una Chiesa ben preservata ma inutile e statica. Anche in questo senso don Pino è il volto di una Chiesa «in uscita». Non «in gita», «in vacanza», ma in uscita.
Questa uscita lo ha portato ad amare i nemici. E p. Pino li invitava a venire in chiesa, a dialogare, a conoscersi, a dire le loro ragioni, e non soltanto a uccidere… Egli non voleva tanto convertire i mafiosi, quanto invitare tutti a solidarizzare, ad aiutarsi, a cercare il bene del quartiere. La morte di p. Pino è stata insieme un seme di resurrezione per il quartiere Brancaccio, per Palermo e l’intera Sicilia, per il nostro Paese e la Chiesa tutta.
La resurrezione ha un nome preciso che è quello che il Papa ha dato a pizza Politeama il 15 settembre 2018: «fare andare avanti la speranza» sapendo che «la speranza sorgerà a Palermo, in Sicilia, in Italia, nella Chiesa a partire da voi». Ci vuole un cuore giovane e lottatore per «non cedere alla logica dell’irredimibile». «No al fatalismo, no al pessimismo», ha chiesto il Papa. E ha aggiunto: «voi avete nelle mani la capacità di fare la speranza, di fare andare avanti la speranza».
Oggi la Chiesa italiana è chiamata a svolgere un ruolo profetico. Non un ruolo egemonico, ma profetico. La Chiesa o è profetica o non è. Ed è chiamata a ricucire le coscienze con il Vangelo. A volte ci siamo talmente abituati a parlare di “dottrina cristiana” che ci di aver perso il legame tra la dottrina e il Vangelo. A volte persino non riconosciamo più il Vangelo e le sue parole e diamo credito a profeti di sventura che istillano nei nostri cuori la paura. Oggi, proprio oggi, abbiamo bisogno di profeti come don Pino che condensa il Vangelo nel sorriso davanti al suo assassino.
In altre parole, per dirla con mons. Lorefice, «Abbiamo bisogno di uomini e donne che fanno quel che dicono… e che dicano no al gattopardismo dilagante». Dobbiamo rifiutarci di seguire ciò che leggiamo nel Gattopardo: «Viviamo in una realtà mobile alla quale cerchiamo di adattarci come le alghe si piegano sotto la spinta del mare».
Padre Pino è parte di quella speranza che supera ogni rassegnazione. Noi siamo chiamati a essere «alla maniera di» padre Pino. Essere liberi e forti significa non adattarsi come le alghe al flusso delle onde. Significa stare dritti. E in piedi. Anzi: camminare diritti.





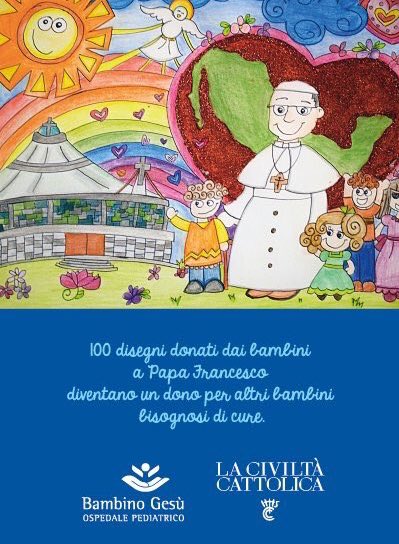







 La scelta di
La scelta di  Ecco l’altra domanda: la tecnologia ha a che fare con la questione della «verità»? Proprio questa domanda è stato lo «start up» di Civiltà Cattolica, a prescindere dal fatto che si concordi o meno con le sue posizioni, nel tempo discutibili. Il fatto che si stampino 17 fogli al minuto, come allora, o che una notizia arrivi istantaneamente a un numero indefinito di persone, come oggi, solleva il problema di che cosa sia la verità e quale essa sia. Se prima l’alternativa era tra verità o eresia, adesso è tra verità o propaganda retorica ed emozionale. E forse non è un caso che l’espressione post-truth sia apparsa per la prima volta sulla più antica rivista culturale degli Stati Uniti,
Ecco l’altra domanda: la tecnologia ha a che fare con la questione della «verità»? Proprio questa domanda è stato lo «start up» di Civiltà Cattolica, a prescindere dal fatto che si concordi o meno con le sue posizioni, nel tempo discutibili. Il fatto che si stampino 17 fogli al minuto, come allora, o che una notizia arrivi istantaneamente a un numero indefinito di persone, come oggi, solleva il problema di che cosa sia la verità e quale essa sia. Se prima l’alternativa era tra verità o eresia, adesso è tra verità o propaganda retorica ed emozionale. E forse non è un caso che l’espressione post-truth sia apparsa per la prima volta sulla più antica rivista culturale degli Stati Uniti, 